
|
|
|
Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica (A.I.S.M.) |
|
|
|
|
|
|
 |  | | STORIA DELLA PARAPSICOLOGIA | | DA RHINE AD OGGI | | |
|  | | |
STORIA DELLA PARAPSICOLOGIA: DA RHINE AD OGGI
Giuseppe G. Perfetto
Nel breve tempo di una lezione di settanta minuti mi è impossibile riassumere gli ultimi settant’anni di storia della parapsicologia. Piuttosto che presentare un elenco sommario di date e nomi preferisco portare la vostra attenzione su alcuni ma fondamentali capitoli di questa storia, rinviando ai testi generali riportati in bibliografia chi fosse interessato all’approfondimento di tutte le altre tematiche.
Storicamente Rhine è considerato colui che ha condotto la ricerca parapsicologica all’interno della scienza e ciò grazie al sistematico utilizzo della metodologia quantitativa.
Come brillantemente illustrato nella precedente relazione, vi sono dei precisi antecedenti storici al lavoro di Rhine. Già nel 1884 Charles Richet servendosi di semplici mezzi, come le normali carte da gioco, inaugurò i primi studi quantitativi sulla telepatia i quali comprendevano una convalida dei risultati attraverso l’elaborazione del calcolo delle probabilità. Ma sarà grazie all’influenza di uno dei maggiori psicologi del mondo, William McDougall, che la metodica applicazione della statistica alle ricerche parapsicologiche porterà i suoi successi scientifici.
William McDougall (1871-1938) si era principalmente occupato degli aspetti intenzionali dell’attività mentale, d’ereditarietà e della questione della relazione mente-corpo. McDougall non si dedicò personalmente alla ricerca parapsicologica, se non in modo marginale, ma ne fu un fervente sostenitore, infatti aveva idee molto precise su quello che doveva essere il futuro della parapsicologia: innanzi tutto essere sottratta al dilettantismo, la ricerca e lo studio dovevano essere condotti a livello professionale con rigore metodologico e continuità, questa scienza doveva avere un suo legittimo e riconosciuto posto all'interno delle università a fianco alla psicologia.
Nei primi anni ’20 insegna all'Harvard University, durante la sua permanenza, nonostante l’avversione dei colleghi, cerca con ogni mezzo di instaurare le condizioni propizie per l'inserimento della ricerca psichica nell’università, adoperandosi perché la parapsicologia fosse accettata e i suoi studi scientifici introdotti in ambito accademico. Sono di questo periodo le pionieristiche ricerche dello psicologo George Estabrooks, assistente di McDougall alla cattedra di Psicologia, che servendosi di normali carte da gioco utilizzò metodi quantitativi molto simili a quelli adottati dal Rhine pochi anni dopo.
Nel 1927 McDougall lascia Harvard per andare a dirigere il Dipartimento di Psicologia alla Duke, una nuova e molto dinamica università sorta nella piccola città di Durham, nella Carolina del Nord. Qui trovava finalmente l'ambiente adatto per realizzare i suoi progetti parapsicologici, ed è a questo punto della storia che fa la sua comparsa Rhine.
Josef Banks Rhine nasce il 29 settembre 1885 in Pennsylvania, inizialmente indirizza i propri studi verso la teologia, in seguito si dedica alla botanica e alla ricerca scientifica nel settore della biologia vegetale finché nel 1925 si laurea in Scienze Naturali presso la Chicago University. Assieme alla moglie Louisa ottiene un buon posto alla West Virginia University, ed entrambi iniziano una promettente carriera nell’ambito della botanica. Nel frattempo iniziano ad interessarsi sempre più appassionatamente di ricerca psichica, finché verso il ’26 prendono la decisione di dare una svolta alla loro vita: decidono di occuparsi attivamente di parapsicologia, abbandonano la cattedra di Biologia Vegetale e per meglio introdursi nell’ambito iniziano ad occuparsi di psicobiologia. Nel ‘27 avviene il loro incontro fortunato con William McDougall, e l’anno successivo lo seguono alla Duke University dove inizialmente Rhine ricopre l’incarico d’assistente di psicologia.
Fino al 1929 Rhine assiste McDougall nei suoi esperimenti tesi a confermare la teoria dell’ereditarietà di Lamark sulla trasmissione a generazioni successive di caratteristiche acquisite. Questa particolare esperienza di ricerca impressionò favorevolmente Rhine facendogli comprendere la necessità degli studi statistici alfine di dirimere questioni controverse nella scienza.
Finalmente dal 1930 Rhine ha l’opportunità di iniziare le proprie ricerche in ambito parapsicologico. Originariamente i bersagli erano costituiti da mazzi di carte numerate o con lettere dell’alfabeto. Successivamente Rhine chiese a Karl Zener, uno specialista di psicologia della percezione, di creare una nuova serie di carte che potevano essere facilmente distinguibili e memorizzabili: la soluzione fu il noto mazzo di carte Zener o ESP, costituito da cinque simboli (cerchio, stella, quadrato, onde, croce), che nelle intenzioni dell'ideatore dovevano essere anonimi e suscitare scarse reazioni emotive nei soggetti sperimentali.
I protocolli di ricerca prevedevano la messa a punto di sistemi che producessero sequenze casuali di una serie prefissata di bersagli che il soggetto doveva “indovinare” senza ricorrere alla percezione sensoriale o ad inferenze razionali; facendo riferimento all’attesa statistica si poteva calcolare la significatività degli eventuali risultanti anomali (o non casuali) delle prove. Sulla base di tali procedimenti, si mirava a portare entro condizioni controllate la manifestazione parapsicologica ricorrendo a metodologie molto simili a quelle impiegate nella ricerca psicologica di laboratorio dell’epoca.
Le ricerche originariamente partite dalla telepatia si estesero presto alla chiaroveggenza e dal ’33 alla precognizione, abbracciando una fenomenologia da Rhine definita “percezione extra-sensoriale” divenuta nota sotto la sigla ESP; a questi studi dal 1935 si aggiunsero le prime autentiche ricerche sperimentali sull’azione paranormale della mente sulla materia, ovvero ciò che egli chiamò “psicocinesi “ (sigla PK), basate sull’influenzamento della caduta dei dadi.
Rhine si riprometteva tre scopi: affermare la parapsicologia come scienza, farla entrare nei laboratori universitari e stabilire la natura non fisica della psi.
Fortemente motivato delle implicazioni scientifiche, politiche e religiose che il suo lavoro poteva avere, del resto sempre condivise e sostenute dalla moglie, assieme ad una piccola equipe condusse migliaia e migliaia di prove. Questi sono anni d’entusiasmo e di autentico fervore sperimentale: alla Duke si stabilisce un ambiente favorevole che attira centinaia di studenti che non si stancano di ripetere migliaia di volte monotoni esperimenti di card guessing.
Secondo Rhine, solo dopo una precisa analisi dei risultati in termini di condizioni sperimentali si può raggiungere un giudizio definitivo circa il verificarsi di un’ipotesi ESP. Prima che si possa determinare l'incidenza dell'ESP nei risultati sperimentali è necessario:
formulare precisamente i termini stessi della questione, descrivere dettagliatamente i procedimenti di prova usati nell'indagine, considerare quali ipotesi alternative o contrarie potrebbero concepibilmente applicarsi ai risultati ottenuti ed infine considerare quali criteri si richiedano per giungere a una conclusione. A parere di Rhine, il metodo statistico è l'unico che poteva risolvere la difficoltà di determinare che cosa fosse dovuto al caso e cosa possa essere attribuito ad altri fattori.
Come abbiamo sottolineato, gli esperimenti di Rhine basati sull'uso delle carte (o bersagli analoghi) e sulla valutazione statistica dei risultati non erano una novità, furono condotte ricerche pionieristiche alcuni decenni prima in Francia, Inghilterra e America, però si trattò di lavori sporadici e saltuari, solo con Rhine la ricerca quantitativa divenne sistematica e continuata. Ma la vera originalità della sua opera sta nel fatto che alla Duke non si tentava tanto di dimostrare la realtà delle manifestazioni paranormali, quanto escogitare metodologie di studio con le quali tali fenomeni potessero essere ripetuti da chiunque in qualsiasi laboratorio, portando così la ricerca parapsicologica su di un piano veramente scientifico; per questo Rhine si valse di prevalentemente di soggetti comuni, volontari non selezionati perlopiù studenti, mirando a rilevare statisticamente in loro un livello minimo di sensitività: quel grado cioè che si poteva rinvenire in qualsiasi individuo e che poteva essere verificato da qualsiasi sperimentatore.
Nel 1934 esce il suo primo libro: “Extra-Sensory Perception”, con una prefazione di McDougall. Per la prima volta il mondo della psicologia accademica si interessò apertamente al problema dell'esistenza dell'ESP e ne nacque un’animatissima discussione.
Nel 1935 costituisce all’interno della Duke University il Parapsychology Laboratory, ricoprendone la direzione per trent’anni.
Dal 1937 avvia le pubblicazioni del “Journal of Parapsychology”, dirigendolo fino al 1958, che allora era l'unica rivista di parapsicologia sperimentale: inizialmente ospitava quasi esclusivamente i resoconti delle esperienze sperimentali del Parapsychology Laboratory e col tempo si è imposta come una delle più importanti riviste internazionali del settore.
Nel 1940 appare un secondo libro “ Extrasensory Perception after Sixty Years”, scritto da Rhine assieme ai collaboratori dello staff del Parapsychology Laboratory: J.G. Pratt, B.M. Smith, C.E. Stuart, J.A. Greenwood.
Nel tempo seguono altri testi, di genere maggiormente divulgativo: “New frontiers of the mind” del 1937, ”The reach of the Mind” del 1947 e nel 1957 “ New world of the Mind”.
Intanto controversie, critiche sulle tecniche impiegate, sulle precauzioni sperimentali, sull'interpretazione dei risultati ridussero il creativo e sereno ambiente del Parapsychology Laboratory sino a divenire una sorta di fortezza da difendere. Il 1950 abbandona l’incarico di Professore di Psicologia alla Duke University per dedicarsi esclusivamente alle attività del laboratorio e nel 1962 libera il suo istituto di parapsicologia da ogni legame universitario fondando la Foundation for Research on the Nature of man, creata da Rhine con lo scopo di promuovere e coordinare le ricerche parapsicologiche a livello internazionale.
Il 1957 promuove la costituzione della Parapsychological Association, l’associazione di categoria dei parapsicologi di tutto il mondo, che il 30 dicembre 1969 entrata a far parte dell’Associazione Americana per il Progresso della Scienza (AAAS), la più prestigiosa associazione di istituzioni scientifiche del mondo, in riconoscimento dell'appropiatezza dell’uso di metodi scientifici nell’indagine parapsicologica.
Rhine è eletto presidente della Society for Psychical Research nel 1979. Muore il 20 febbraio 1980 all’età di 84 anni.
Rhine afferma di avere dimostrato che l'uomo possiede delle capacità che non dipendono nè dei sensi, nè dal tempo, nè dallo spazio. Egli riteneva di aver risolto la ricerca proof-oriented, la convalida della prova, per passare alla fase proces-oriented ovvero della ricerca del come sarebbe avvenuto il fenomeno.
Al termine della sua lunga carriera, Rhine dichiara di avere rafforzato alcune convinzioni in merito ai fenomeni parapsicologici, esse possono essere così riassunte:
- fondamentalmente telepatia, chiaroveggenza e precognizione sono manifestazioni della stessa capacità (ESP) e il concetto può estendersi all'interazione fra soggetto e oggetto (PK) concependo entrambi i processi come una forma d'interazione fra l’uomo e l’ambiente
- alla base della fenomenologia psi vi è un’energia extrafisica responsabile sia della percezione extrasensoriale sia della psicocinesi, la quale potrebbe essere convertita in energia fisiologica del sistema nervoso centrale alfine di portare alla coscienza le capacità paranormali inconsce
- considerata come attività psicologica, il processo della percezione extrasensoriale è interamente inconscio, in genere irregolare, altamente instabile, apparentemente spontanea ed involontaria
- l’ESP è promossa quando il soggetto (così come lo sperimentatore) è fortemente motivato;
- l’ESP ha il carattere della percezione sensoriale
- la percezione extrasensoriale è un fenomeno naturale non fisico.
Alla Duke University oltre al lavoro sperimentale vi è stata una lunga attività di ricerca sulla casistica spontanea portata avanti da Louisa Rhine le cui indagini, nettamente di tipo qualitativo, sono venute ad integrare quelle quantitative del marito. A partire dal 1948 Louisa Rhine ha raccolto e classificato oltre 7300 casi di fenomeni spontanei ESP e PK, formalizzando l’indagine in questo settore di studio. Secondo la Rhine un caso è ritenuto degno di analisi quando risponde a certi requisiti minimi: veridicità, esistenza di almeno un teste al quale l'esperienza psi spontanea sia stata riferita tempestivamente ed esistenza di un resoconto scritto non oltre cinque anni dall'esperienza stessa.
Frattanto, nel 1953, ad Utrech si tenne uno storico Congresso Internazionale di Parapsicologia, nel quale la parola “Parapsicologia” fu ufficialmente adottata al posto delle desuete "ricerche psichiche” e di “metapsichica”, non solo per unificare la terminologia ma soprattutto per eliminare tutti quei termini che potevano suggerire significati metafisici, religiosi o spirituali.
Il rigore metodologico di Rhine consentì l’accettazione delle indagini parapsicologiche entro l’ambito scientifico ed accademico.
Sulla scia del successo della scuola di Rhine, e dell’esperienza alla Duke, sorsero diversi istituti di parapsicologia in seno ad organizzazioni universitarie.
Nel 1956 Hans Bender creò, presso l’università di Friburgo, una cattedra di parapsicologia e l’”Istituto per i Territori di Confine della Psicologia e dell’Igiene Mentale”. Bender si è occupato principalmente di fenomenologia spontanea, di sogni paranormali e di RSPK, in particolare citiamo il noto caso del poltergeist di Rosenheim che costituisce a tutt'oggi un autentico modello di osservazione ed indagine scientifica.
Un’altra cattedra di parapsicologia fu fondata ad Utrech, in Olanda, nel 1953, prima sotto la direzione di Hendik W.K. Tenhaeff poi di Martin Jhonson: entrambi si occuparono principalmente dello studio psicologico delle fenomenologie psi.
Nel 1985 una nuova cattedra di parapsicologia è fondata presso l’Università di Edimburgo, in Scozia, a dirigerla, è un allievo del Rhine, Robert Morris che compie importanti ricerche in merito ai parametri psicologici che condizionano i fenomeni paranormali e più recentemente sta conducendo sperimentazioni sul ganzfeld.
Un laboratorio di ricerca parapsicologica è sorto presso l’Università di Leningrado, che dal 1960 sotto la direzione del fisiologo Leonid Vasljev ha condotto fondamentali scoperte sul funzionamento della percezione extrasensoriale.
Per quanto riguarda la situazione italiana, a Roma fu fondata nel maggio del 1937 la Società Italiana di Metapsichica (S.I.M.), per iniziativa di Ferdinando Cazzamalli (medico e docente universitario di Neuropsichiatria presso l’Università di Roma), Giovanni Schepis (docente universitario di Statistica presso l’Università di Roma), Emilio Servadio (professore onorario di Psicologia, presidente della Società Psicoanalitica Italiana) e Luigi Sanguineti (medico neuropsichiatra). La Società Italiana di Metapsichica fu la prima organizzazione italiana sorta col precipuo scopo di studiare scientificamente e sistematicamente i cosiddetti fenomeni paranormali. La Società ebbe con decreto del 23 maggio 1941, con conferma nel 1949, il riconoscimento ufficiale dello Stato. Nel 1946 Cazzamalli si allontana dalla S.I.M. per divergenze ideologiche e metodologiche e crea a Milano l’Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica (A.I.S.M.) con lo scopo di promuovere lo studio scientifico-sperimentale della fenomenologia parapsicologica, con i metodi e col rigore che assicurano il progresso di altre branche della scienza. A Bologna viene creato nel 1954 il Centro Studi Parapsicologici, sempre contraddistintosi per rigore metodologico e aderenza ai canoni scientifici. Il C.S.P. e l’A.I.S.M. sono a tuttora i due più importanti istituti italiani di ricerca scientifica nel settore della parapsicologia.
Sempre nel panorama italiano è doveroso almeno citare il lavoro dello psicoanalista Emilio Servadio, che dal 1935 pubblica una serie di articoli che fanno luce sulla psicodinamica delle manifestazioni psi. I risultati principali cui Servadio è pervenuto possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- il substrato dell’ESP è rappresentato da relazioni interpersonali emotivamente significative
- questi rapporti si possono far risalire all’infanzia, il che spiega il maggior manifestarsi dell’ESP fra consanguinei (in particolare madre-figlio)
- l’ESP costituirebbe una sorta di comunicazione arcaica e primitiva
- il movente inconscio dell’ESP è spesso l’angoscia di separazione, vissuta come perdita dell’oggetto
- condizioni affinché il fenomeno paranormale accada è il verificarsi da parte della coppia di una comune tendenza regressiva, che tende a ridurre la loro individuazione-separazione
- il fenomeno telepatico è strutturalmente inconscio.
Un’altra tappa fondamentale della storia della parapsicologia è rappresentata dalla pubblicazione delle ricerche nel 1958 della psicologa Gertrude Schmeidler che dimostrarono come i soggetti che non sono convinti nell'esistenza dell'ESP, detti "capre", hanno in genere una media di punteggi positivi più bassa dei soggetti che invece credono nell'ESP, indicati come "pecore" che invece manifestano punteggi che sono quasi costantemente al di sopra della media. E’ importante rilevare come tale effetto si ripeté costante nelle successive indagini sperimentali: per esempio Jhon Palmer prese in esame tutti gli studi sull’effetto pecora/capra condotti dal 1958 al 1968, un totale di 17 esperimenti condotti da 12 diversi sperimentatori indipendenti, la conclusione di Palmer fu che tutte le differenze significative fra i due gruppi di soggetti andavano nella direzione prevista, mentre l’effetto opposto non si era mai manifestato in maniera significativa.
Col tempo i parapsicologi costatarono che il metodo rhineiano basato sulla noiosa routine dell’indovinamento di carte, escludeva dalla sperimentazione fondamentali variabili psicologiche ritenute essenziali nelle manifestazioni psi. Avvicinandosi alla fenomenologia spontanea, i bersagli utilizzati furono meno definiti dei simboli Zener, ma maggiormente ricchi di emozione, significato e stimolo motivazionale: immagini, filmati, scene vissute, ecc. Le procedure di convalida ora prevedevano che i responsi del soggetto venissero vagliati da giudici indipendenti in doppio cieco.
In quest'ambito, un originale filone di ricerche fu quello relativo all'indagine parapsicologica sui sogni, infatti vi è un particolarissimo tipo di esperienze psicologiche che si verificano durante lo stato di sonno che implicano una conoscenza per via extrasensoriale di pensieri o avvenimenti esterni al sognatore. La percezione extrasensoriale, come il sogno, è un processo intrinseco alla natura umana: rivela la conoscenza inconscia che l'uomo ha di se stesso e del suo rapporto col mondo. Come anche evidenziato da Louisa Rhine, lo "stato mentale" nel quale più frequentemente si manifestano facoltà di tipo paranormale, o extrasensoriale, è il sogno. Sono moltissimi i resoconti di questo genere di fenomeni onirici raccolti negli archivi degli istituti di parapsicologia e psicologia di tutto il mondo. Si tratta di esperienze che dimostrerebbero la possibilità che i sogni rivelino eventi che si svolgono a distanza e che non si sarebbero potuti immaginare basandosi sulla logica o sul buon senso.
La parapsicologia distingue tre tipi di sogni paranormali, ognuno di essi legato a ciascuna modalità di percezione extrasensoriale: telepatia, chiaroveggenza e precognizione. Nei sogni telepatici il sognatore percepisce per via extrasensoriale idee che in quel momento sono pensate da un'altra persona. Nei sogni chiaroveggenti succede d'assistere a scene che stanno avvenendo in luoghi lontani. I sogni precognitivi, o premonitori, annunciano eventi che devono ancora accadere. Da un punto di vista generale le caratteristiche formali e psicologiche dei sogni paranormali sono: le persone riconoscono questi sogni differenti da quelli ordinari in ragione di una loro peculiare vividezza, impressione ed intensità, il sognatore sente che essi hanno un significato importante e si sente spinto a raccontarlo, sono vissuti onirici che vengono facilmente rievocati al risveglio, frequentemente segnalano episodi inattesi o tragici ed infine non presentano quella bizzarria e quella dinamicità da una scena all'altra tipica dei sogni comuni.
Ma i sogni paranormali, da secoli sospesi fra magia e tradizioni popolari, solamente grazie ai progressi nella comprensione della fisiologia del sonno e con il relativo sviluppo di tecnologie appropriate, troveranno a partire dagli anni ‘60 una loro credibilità scientifica quando verranno studiati nel laboratorio del sonno del Maimonides Hospital Medical Center di New York, da un’équipe di psicologi, Montague Ullman, Stanley Krippner, Alan Vaughan e Charles Honorton. Gli esperimenti furono congeniati nel modo seguente: un soggetto veniva invitato a dormire in una camera del sonno insonorizzata in condizioni di controllo psicofisiologico, ovvero venivano registrate l'attività del cervello, con l'elettroencefalografo, oltre ai movimenti oculari, non appena gli strumenti indicavano che era in uno stadio di sonno con sogni (fase REM) un'altra persona gli trasmetteva telepaticamente dei messaggi scelti casualmente (che erano temi complessi con contenuti visivi, emotivi e concettuali in grado di manifestarsi nel sogno). Alla fine della fase di sogno, o dopo una quindicina di minuti di attività REM, si risvegliava il soggetto dormiente e un altro sperimentatore gli chiedeva di raccontare il contenuto dell'esperienza onirica appena avvenuta. Dopo di che un gruppo di giudici esterni, tramite un complicato metodo statistico di comparazione, valutava il grado di corrispondenza fra i messaggi telepatici e il resoconto del sognatore, osservando se nel sogno fossero inseriti elementi o contenuti mentali che il trasmettente gli aveva inviato. In questo modo fu possibile realizzare una lunga serie di esperimenti al Maimonides che iniziati nel 1962 proseguirono fino al '73. In questi dieci anni furono portate a termine tredici sessioni sperimentali: dieci di queste fornirono risultati giudicati statisticamente significativi.
v Una delle caratteristiche sorprendenti dei sogni paranormali è che sovente in essi vengono rappresentati eventi o informazioni futuri. Sempre nel laboratorio del Maimonides si cercò di studiare questi sogni precognitivi. In questi esperimenti il metodo fu ovviamente modificato: il soggetto veniva fatto dormire nella stanza del sonno, lo si risvegliava durante la fase REM e si registravano i suoi sogni. Il mattino successivo veniva scelto, in modo casuale, un disegno e in sede valutativa si osservava se il soggetto avesse sognato la notte precedente qualcosa di analogo all'immagine estratta solo dopo che l'esperienza onirica si era verificata. Anche in questa ricerca i risultati furono giudicati estremamente significativi e furono indicativi di un’oggettiva percezione extrasensoriale avvenuta in stato di sonno.
Nel 1988 Alan Vaughan, uno dei collaboratori del progetto di ricerca, e Jessica Utts, una nota esperta di statistica dell’Università della California, elaborarono una stima globale dei risultati dell'intera sperimentazione del Maimonides: su un totale di 379 tentativi 233 ebbero risultati positivi, con una percentuale di successi dell’83,5% contro un'attesa casuale del 50%, le probabilità di successo fortuito erano poco più di 250.000 contro 1. La ricerca stabilì scientificamente ed inequivocabilmente l'evidenza di fenomenologie paranormali nei sogni.
Negli anni successivi uno degli sperimentatori del Maimonides, Charles Honorton, proseguendo le sue indagini su come gli stati modificati di coscienza possono promuovere l’ESP, utilizzando la tecnica del ganzfeld ha fornito nuovi risultati che hanno ulteriormente dato consistenza scientifica alla parapsicologia.
Il ganzfeld, che letteralmente significa “campo uniforme”, è una condizione sperimentale di deprivazione sensoriale, all’inizio era una tecnica molto utilizzata nell’ambito della psicologia della percezione e in oftalmologia, nel corso del tempo è divenuto un prezioso strumento in parapsicologia sperimentale per lo studio dell’ESP.
La metodica tipicamente prevede che, nel caso della telepatia, il percipiente sia comodamente sdraiato su una poltrona reclinabile, in un ambiente confortevole e rilassante, in una stanza isolata e in penombra. Al soggetto sono applicati sugli occhi delle semisfere di celluloide traslucida contornate da materiale morbido nell’area perioculare (in pratica due mezze palline da ping-pong al disotto delle quali viene posto del cotone), davanti è posta una luce colorata, a poco più di un metro, di solito rossa, che procura un’indistinta percezione di luminosità rosata di omogenea intensità proveniente da ogni direzione. Dopo di che viene fatto ascoltare, attraverso una cuffia stereofonica, del “rumore bianco”: un suono monotono come un fruscio continuo. In questa condizione psicofisica d’isolamento sensoriale, il soggetto è invitato a descrivere tutte le sensazioni, in particolare le immagini visive, che gli passano per la mente per libera associazione. Frattanto, in un altro luogo un agente (o trasmittente) si concentra su un’immagine, oppure su un filmato, proiettato secondo modalità casuali da un monitor. Alla fine della prova il soggetto decide fra quattro bersagli (immagini o filmati) quale ritiene essere quello “inviato” dal soggetto trasmittente oppure, secondo il disegno sperimentale, un gruppo di giudici indipendenti valuta l’accoppiamento fra resoconto del percipiente e i quattro bersagli random. Pertanto in queste ricerche l’attesa statistica casuale d’indovinamento è di uno su quattro, ¼, in altre parole del 25%.
Tali indagini sperimentali sono state analizzate seguendo un procedimento statistico detto “meta-analisi” che consiste nell’esaminare globalmente numerosi esperimenti omogenei per metodologia, in modo da far emergere risultati significativi costanti. Le meta-analisi sono un procedimento largamente impiegato in tutte le scienze e hanno sempre fornito eccellenti soluzioni: per esempio solo dall'anno scorso ad oggi, e solo in ambito medico, sono stati pubblicati qualcosa come oltre duecento studi di meta-analisi.
Le prime meta-analisi di Honorton compiute su 28 esperimenti ganzfeld, condotti dal 1974 al 1981, hanno portato ad una significativa media percentuale di successi del 35%, con variazione 28%-43% (ricordo che l’attesa casuale è del 25%).
I dati complessivi sino al 1980 mostravano percentuali di successo che oscillavano dal 50% al 58%.
Nel 1985 Hyman e Honorton pubblicarono un celebre joint communiqué nel quale concordarono sul fatto che, benché questo primo database di esperimenti avesse prodotto esiti positivi, la risposta sull'esistenza dell’ESP doveva essere rimandata ad ulteriori esperimenti condotti Con standard di controllo maggiormente severi.
Arriviamo così all’importante di Bem e Honorton del 1994, apparso sulla prestigiosa rivista Psychological Bulletin, organo di stampa dell’American Psychological Association. Sulla scorta delle critiche metodologiche dello scettico Hyman, ovvero secondo le linee direttrici concordate nel comunicato congiunto, si eseguirono tra il 1983 e il 1989, una nuova serie di sessioni sperimentali, 354 prove per un complessivo di 11 esperimenti con un sistema totalmente computerizzato detto autoganzfeld: con questa procedura si confermarono i precedenti esiti, infatti 10 degli 11 nuovi lavori diedero un risultato positivo, fornendo una media complessiva di successi pari al 32%. La probabilità che questo risultato fosse dovuto al caso era di 1 contro 20000. Quando questi risultati si combinarono con i 28 lavori precedenti che usarono lo stesso metodo di valutazione, le probabilità contro il caso divennero astronomiche: oltre diecimila miliardi contro uno. Inoltre si riscontrò che i successi erano significativamente più probabili con target dinamici (videoclip) che su obiettivi statici (immagini fotografiche).
Per quanto riguarda lo studio sperimentale della PK nuovi risultati si ebbero, a partire dal 1969, con lo studio della cosiddetta micro-psicocinesi su Sistemi Generatori di Eventi Casuali. In questo campo lo studioso di maggior spicco fu il fisico Helmut Schmidt. La procedura prevedeva che il soggetto dovesse cercare di influenzare un processo altamente casuale ed imprevedibile, ovvero di accelerare o rallentare il decadimento di particelle radioattive mostrato da un contatore, senza toccare la macchina o la fonte di radioattività.
Un importante sviluppo delle ricerche di Schmidt sono le recenti sperimentazioni di Robert Jahn presso il Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory (PEAR). Si tratta di studi di micro-psicocinesi volti a verificare l'azione della volontà umana su complessi sistemi meccanici, elettronici, ottici. In condizioni di normalità queste apparecchiature producono effetti del tutto casuali, mentre in condizioni di sperimentazione psicocinetica esse mostrano comportamenti anomali attribuibili all'influenza dei soggetti. Al PEAR sono state condotte diverse migliaia di questi esperimenti con centinaia di soggetti e, come spessissimo accade nella ricerca parapsicologica, gli effetti rilevati sono generalmente molto piccoli ma sufficientemente statisticamente significativi da dimostrare una ripetibilità del fenomeno psi.
BIBLIOGRAFIA
Bem D.J., Honorton C., "Does Psi Exist? Replicable Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer", Psychological Bulletin, 1994, N. 1
Broughton R.S., “Parapsicologia”, Sperling & Kupfer Editori, 1994
Cassoli P., “Storia della parapsicologia: da Rhine ai giorni nostri” , 1998
Cassoli P. e B., “La parapsicologia”, Xenia Edizioni, 2000
Inardi M., “Storia della parapsicologia”, Quaderni di Parapsicologia, 1975, N. 6-8
Palmer J., “Scoring in ESP tests as a function of belief in ESP”, Jounal of ASPR, 1972, N. 65-66
Perfetto G., “Parapsicologia psicoanalitica: l’opera di Emilio Servadio”, Quaderni di Parapsicologia, 1995, N. 2
Perfetto G., Dossier “Sonno e Sogni”, Essere, 1998, N. 10
Perfetto G., ”Sperimentazioni sul ganzfeld e meta-analisi”, Quaderni di Parapsicologia, 2002, N. 1
Rhine J.B., “La percezione extrasensoriale”, Metapsichica, 2001
Rinaldi D.M., “Ricordo di J.B. Rhine”, Il mondo della Parapsicologia, 1980, N. 3
Scott Rogo D., “La nuova parapsicologia”, Edizioni Mediterranee, 1997.
Severi B., “La psicocinesi”, http://digilander.iol.it/cspbologna/, 2001
Wolman B.B., “L’universo della parapsicologia”, Armenia Editore, 1979.
|
|
|
|
|
|
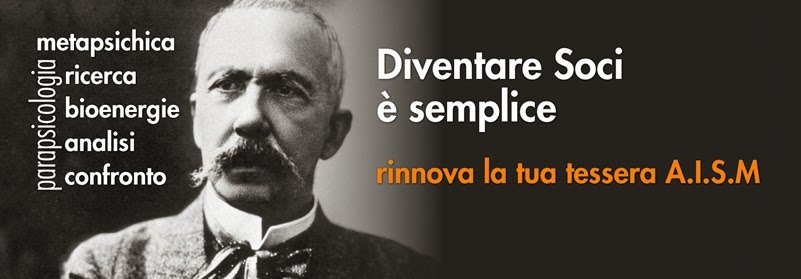
|
|
|


diventa socio aism


|